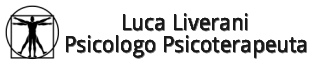Disturbo evitante di personalità

Il disturbo evitante di personalità (DEP) è un disturbo caratterizzato dalla convinzione radicata del soggetto di valere poco; ciò porta la persona a sentire un profondo senso di inadeguatezza nella vita di relazione, con un enorme timore delle critiche, della disapprovazione altrui e di esclusione. Per evitare queste esperienze dolorose e la sensazione di sentirsi escluso dagli altri, la persona con disturbo evitante di personalità tende ad avere una vita ritirata; il ritiro sociale, seppur conduce ad una esistenza priva di stimoli, triste, con un visibile senso di vuoto e, a volte, quasi senza senso, evita alla persona di esporsi e di vivere il malessere dell’inferiorità e del senso di inadeguatezza.
Questi soggetti, non hanno un gruppo di amici con i quali uscire la sera e sul lavoro si mantengono ai margini rinunciando alla carriera per non essere sottoposti al giudizio altrui; tuttavia desiderano fortemente istaurare delle relazioni, poter avere un partner, condividere esperienze ed interessi con i gli altri. Ma la difficoltà a vivere l’imbarazzo o l’umiliazione li induce ad evitare il confronto.
Si tratta di un disturbo comune nelle popolazioni cliniche con una prevalenza dell’1-10%. Ad oggi non abbiamo informazioni chiare su come si distribuisce nei due sessi o sulla presenza di familiarità.
Le persone affette da disturbo evitante sono caratterizzate da problemi relazionali associati ad un radicato senso di inadeguatezza e timore del giudizio negativo altrui; manifestano, infatti, un elevato grado di inibizione e ritiro sociale, legato al fatto che ritengono che la valutazione negativa dagli altri sia un dato di fatto. Preferiscono allora tenersi fuori dalle relazioni, ad eccezione di quelle abituali e rassicuranti (es. con i familiari più stretti), pur desiderando di avere delle relazioni sociali. Queste persone, infatti, sentono come gli altri il bisogno di una vita di relazione soddisfacente, che rimane, però, inespresso; questo comporta un estremo malessere che può essere sperimentato come senso di vuoto o come un doloroso senso di esclusione.
Assistono in questo modo allo svolgimento della vita degli altri come se fossero in un film di cui sono spettatori passivi; vivono costantemente la distanza dagli altri, nelle situazioni di coppia non riescono a trovare elementi di condivisione con l’altro, così come non sentono di appartenere ad alcun gruppo.
Quando si trovano a confrontarsi con le altre persone vivono il disagio della sensazione di non essere visti, di non essere considerati, alla stregua di persone di poco valore; questa esperienza favorisce il mantenimento della convinzione di valere poco e di non avere abilità sufficienti a stabilire e mantenere una pur minima relazione. Si sentono, infatti, incapaci nell’approccio e nel mantenere un discorso, hanno l’idea di non avere nulla di interessante da proporre agli altri e di non essere attraenti.
Ricorrono, quindi, all’evitamento come unico comportamento autoprotettivo da ciò che provoca malessere, dalle proprie emozioni negative; tale comportamento non permette loro di sviluppare quelle risorse ed abilità necessarie nelle relazioni, così come la capacità di venire a contatto con le proprie emozioni. Per poter vivere sensazioni positive e gratificanti, anche se momentanee, coltivano interessi ed attività solitarie (es. musica, lettura, chat) che non implicano necessariamente un contatto con gli altri; in alcuni casi ricorrono anche all’uso di sostanze, in particolare dell’alcool, per sedare il malessere interiore ritagliandosi così una parentesi di piacere virtuale. Talvolta è possibile che questo stile di vita povera di stimoli, monotona contribuisca all’insorgenza di un quadro depressivo.
Quando riescono a stabilire una relazione, in genere, le persone con DEP tendono ad assumere un atteggiamento sottomesso per il timore di perderla e di ritornare ad essere soli; si attaccano, quindi, con tenacia all’altra persona assecondandola per evitare il rifiuto temuto. Con il passare del tempo, tuttavia, tale situazione di costrizione può indurre a reazioni di rabbia non sempre controllate; i soggetti con questo disturbo, infatti, possono non tollerare l’idea di dover vivere il rapporto di coppia come se fosse l’unica via d’uscita ed esplodere quando devono affrontare le difficoltà con il proprio partner.
L’evitante si sente diverso ed inadeguato rispetto agli altri e considera questa condizione come immutabile. Tende allora a restare solo, a casa, in famiglia, lontano dal mondo, con la sensazione che la vita non possa riservargli piacevoli sorprese. Desidera liberarsi da questo stile di vita che si ripete monotono, ma quando tenta un qualsiasi approccio con le altre persone, si ritrae temendo il giudizio negativo ed il rifiuto non ritenendosi all’altezza del confronto; si comporta allora in maniera impacciata, per rifugiarsi poi nella fuga.
Dal momento che è possibile riscontrare la presenza di alcune di queste caratteristiche anche in altri disturbi psicologici, è opportuno chiarire alcune distinzioni tra il disturbo evitante di personalità ed altre condizioni che possono sembrare apparentemente simili.
Il disturbo evitante, in generale, va differenziato dai disturbi d’ansia o dalladepressione, che possono rappresentare fasi transitorie del disturbo legate alle diverse circostanze di vita, e da coloro che reagiscono con timidezza e con comportamenti di evitamento in situazioni che vivono come problematiche e stressanti.
Questo disturbo va, inoltre, distinto da altre patologie con caratteristiche simili con cui può essere confuso, che sono:
Il disturbo evitante esordisce nella tarda adolescenza e prima età adulta; esistono casi in cui tratti marcati di timidezza oppure di altre manifestazione dei disturbi d’ansia sociale si manifestano nell’infanzia e precedono lo sviluppo successivo di una personalità evitante.
Alcuni autori sostengono che aspetti evitanti appaiono precocemente e derivano in parte da fattori biologici temperamentali innati. Tale predisposizione biologica non sarebbe però sufficiente per determinare lo sviluppo del disturbo.
Sono state descritte come altri possibili fattori di rischio, infatti, storie di abusi fisici, storie di rifiuto da parte dei genitori, atteggiamenti che vengono rinforzati dal rifiuto dei coetanei, precoci esperienze di vita che hanno condotto ad un esagerato desiderio di accettazione e ad un’intolleranza alle critiche. Ad esempio, un bambino oggetto di continui scherzi ed umiliazioni da parte coetanei potrebbe rifugiarsi nel proprio mondo familiare, compatto e chiuso, che percepisce come rassicurante nei confronti di un ambiente esterno fatto di persone minacciose e rifiutanti, e sviluppare negli anni delle caratteristiche di personalità evitanti.
Diversi pazienti riescono a mantenere un discreto funzionamento sociale e lavorativo, organizzando il loro stile di vita in un ambiente familiare e protetto. Tendono a mantenere il proprio lavoro negandosi ambizioni di carriera e quindi di confronto; si limitano a vivere le ristrette relazioni abituali, generalmente quelle familiari. Se il loro sistema di supporto cede, tuttavia, vanno incontro a depressione, ansia e collera. L’umore depresso è una delle motivazioni che può spingere il paziente a richiedere l’intervento psicologico. Tale aspetto sintomatologico può diventare anche molto serio, per sfociare anche in ideazione suicidaria. Per affrontare il malessere legato all’ansia o alla depressione, a volte i pazienti evitanti possono fare uso di sostanze, in particolare di alcolici; tale abitudine a volte può assumere le caratteristiche di una vera e propria condotta di abuso, che va ad accrescere l’isolamento del paziente che vede la propria immagine e la propria autostima crollare inesorabilmente. Nel complesso, il paziente evitante tende ad accettare con fastidio l’abitudine alla solitudine e vive rassegnato circa la possibilità di recuperare un’accettabile vita di relazione; convive con la propria solitudine, a volte con rimpianto, altre volte con fastidio.
Differenti tipi di trattamento
Da quando il disturbo evitante di personalità è stato descritto, sono stati effettuati solo pochi studi per valutare l’efficacia clinica dei diversi protocolli terapeutici.
In generale si sono rivelati efficaci i trattamenti psicoterapeutici individuali e di gruppo con caratteristiche supportivo-espressive. L’obiettivo comune è quello di regolare empaticamente l’imbarazzo e l’umiliazione del paziente quando si trova in situazioni sociali.
Le modalità terapeutiche utilizzate sono spesso associate a strategie comportamentali e di skill training per incoraggiare l’esposizione della persona alle situazioni temute ed incrementare le abilità sociali.
I training assertivi all’interno di una terapia cognitivo-comportamentale possono migliorare l’autostima delle persone.
Generalmente, il lavoro psicoterapeutico contribuisce a diminuire il disagio emotivo delle persone e permette loro di confrontarsi con meno timori alla vita relazionale e sociale. Riteniamo opportuno consigliare simili strategie solo quando il paziente appare in grado di definire e riconoscere i propri pensieri e le proprie emozioni, ed è pronto quindi a cercare di affrontare le situazioni problematiche.
La terapia di gruppo può aiutare i soggetti a capire gli effetti che la loro sensibilità al rifiuto ha su di loro e sugli altri; riteniamo necessario non trascurare nelle prime fasi del trattamento un approccio psicoterapeutico individuale, questo per il livello d’ansia che le prime sedute di gruppo potrebbe generare nel paziente e per favorire la costruzione di una salda relazione terapeutica.
Il trattamento farmacologico viene usato in determinate fasi del trattamento e in combinazione con altri interventi, per gestire aspetti sintomatici come ansia e depressione. Vengono utilizzati ansiolitici (es. alprazolam) che aiutano a gestire la riacutizzazione ansiosa o brevi episodi di panico causati dal dover affrontare situazioni solitamente evitate, oppure farmaci betabloccanti per gestire l’iperattività del sistema nervoso autonomo che si ha quando si affrontano situazioni temute. Gli inibitori della ricaptazione della serotonina (es. fluoxetina, paroxetina) si sono rivelati efficaci nella gestione di sintomi tipici della fobia sociale, e possono essere utili nel complesso nei confronti della sensibilità al rifiuto e della timidezza.
Comunque il disturbo evitante sembra rispondere abbastanza bene alla terapia cognitivo-comportamentale a medio-lungo termine (da uno a due anni) come anche a interventi di social skills training.
La psicoterapia cognitivo-comportamentale
Il nucleo centrale del disturbo evitante è la sensazione dolorosa di non riuscire a condividere l’esperienza con gli altri e ad appartenere ai gruppi. Tale sensazione di distacco interpersonale viene favorita e mantenuta dalla difficoltà che i pazienti hanno nel monitoraggio metacognitivo, ovvero nel riconoscere e descrivere le proprie emozioni e i propri pensieri. E’ necessario allora intervenire subito su questo aspetto, poiché la non consapevolezza degli stati di sofferenza emotiva, comporta che nessun intervento di comprensione e condivisione sarà possibile.
In particolare, la difficoltà ad identificare gli stati interni, si accompagna alla tendenza a creare cicli interpersonali quando i pazienti entrano in contatto con gli altri: possono sentirsi inadeguati e per questo esclusi (“Quando le persone capiscono chi sono, mi evitano”); possono sentirsi distaccati (“Non capisco gli altri e gli altri non capiscono me”) o costretti nelle relazioni (“Sono costretto a tollerare la presenza degli altri”). Tale funzionamento alimenta il distacco interpersonale e le difficoltà di comunicazione anche nella relazione terapeutica.
Il passo seguente è quello di incrementare le capacità di collegare i propri pensieri e le emozioni che si provano alle variabili esterne; questo anche attraverso tecniche cognitive standard (come compiti di auto-osservazione, tecniche di ristrutturazione cognitiva o di role-playing).
Soltanto successivamente si cercherà di portare il paziente a sperimentare nuove strategie di padroneggiamento delle difficoltà relazionali efficaci come autoimposizione di un comportamento o l’autoesortazione per verificare e confutare all’esterno le proprie convinzioni errate circa le relazioni e acquisire o incrementare quelle abilità sociali che nel tempo si sono impoverite.
Altro aspetto fondamentale su cui intervenire è il decentramento, ovvero la tendenza che i pazienti evitanti hanno di interpretare le intenzioni e i pensieri degli altri secondo proprio punto di vista disfunzionale ed egocentrico.
Durante l’intero trattamento sarà necessario riconoscere e modulare i cicli interpersonali. Attraverso una linea strategica mirata ad incrementare l’esperienza condivisa tra paziente e terapeuta; la condivisione dell’esperienza ridurrà il rischio che il terapeuta venga percepito critico o giudicante e aumenterà il senso di sicurezza del paziente rispetto all’incontro con un estraneo quale il terapeuta.
In altre parole, il modello di trattamento metacognitivo-interpersonale è:
Questi soggetti, non hanno un gruppo di amici con i quali uscire la sera e sul lavoro si mantengono ai margini rinunciando alla carriera per non essere sottoposti al giudizio altrui; tuttavia desiderano fortemente istaurare delle relazioni, poter avere un partner, condividere esperienze ed interessi con i gli altri. Ma la difficoltà a vivere l’imbarazzo o l’umiliazione li induce ad evitare il confronto.
Si tratta di un disturbo comune nelle popolazioni cliniche con una prevalenza dell’1-10%. Ad oggi non abbiamo informazioni chiare su come si distribuisce nei due sessi o sulla presenza di familiarità.
Le persone affette da disturbo evitante sono caratterizzate da problemi relazionali associati ad un radicato senso di inadeguatezza e timore del giudizio negativo altrui; manifestano, infatti, un elevato grado di inibizione e ritiro sociale, legato al fatto che ritengono che la valutazione negativa dagli altri sia un dato di fatto. Preferiscono allora tenersi fuori dalle relazioni, ad eccezione di quelle abituali e rassicuranti (es. con i familiari più stretti), pur desiderando di avere delle relazioni sociali. Queste persone, infatti, sentono come gli altri il bisogno di una vita di relazione soddisfacente, che rimane, però, inespresso; questo comporta un estremo malessere che può essere sperimentato come senso di vuoto o come un doloroso senso di esclusione.
Assistono in questo modo allo svolgimento della vita degli altri come se fossero in un film di cui sono spettatori passivi; vivono costantemente la distanza dagli altri, nelle situazioni di coppia non riescono a trovare elementi di condivisione con l’altro, così come non sentono di appartenere ad alcun gruppo.
Quando si trovano a confrontarsi con le altre persone vivono il disagio della sensazione di non essere visti, di non essere considerati, alla stregua di persone di poco valore; questa esperienza favorisce il mantenimento della convinzione di valere poco e di non avere abilità sufficienti a stabilire e mantenere una pur minima relazione. Si sentono, infatti, incapaci nell’approccio e nel mantenere un discorso, hanno l’idea di non avere nulla di interessante da proporre agli altri e di non essere attraenti.
Ricorrono, quindi, all’evitamento come unico comportamento autoprotettivo da ciò che provoca malessere, dalle proprie emozioni negative; tale comportamento non permette loro di sviluppare quelle risorse ed abilità necessarie nelle relazioni, così come la capacità di venire a contatto con le proprie emozioni. Per poter vivere sensazioni positive e gratificanti, anche se momentanee, coltivano interessi ed attività solitarie (es. musica, lettura, chat) che non implicano necessariamente un contatto con gli altri; in alcuni casi ricorrono anche all’uso di sostanze, in particolare dell’alcool, per sedare il malessere interiore ritagliandosi così una parentesi di piacere virtuale. Talvolta è possibile che questo stile di vita povera di stimoli, monotona contribuisca all’insorgenza di un quadro depressivo.
Quando riescono a stabilire una relazione, in genere, le persone con DEP tendono ad assumere un atteggiamento sottomesso per il timore di perderla e di ritornare ad essere soli; si attaccano, quindi, con tenacia all’altra persona assecondandola per evitare il rifiuto temuto. Con il passare del tempo, tuttavia, tale situazione di costrizione può indurre a reazioni di rabbia non sempre controllate; i soggetti con questo disturbo, infatti, possono non tollerare l’idea di dover vivere il rapporto di coppia come se fosse l’unica via d’uscita ed esplodere quando devono affrontare le difficoltà con il proprio partner.
L’evitante si sente diverso ed inadeguato rispetto agli altri e considera questa condizione come immutabile. Tende allora a restare solo, a casa, in famiglia, lontano dal mondo, con la sensazione che la vita non possa riservargli piacevoli sorprese. Desidera liberarsi da questo stile di vita che si ripete monotono, ma quando tenta un qualsiasi approccio con le altre persone, si ritrae temendo il giudizio negativo ed il rifiuto non ritenendosi all’altezza del confronto; si comporta allora in maniera impacciata, per rifugiarsi poi nella fuga.
Dal momento che è possibile riscontrare la presenza di alcune di queste caratteristiche anche in altri disturbi psicologici, è opportuno chiarire alcune distinzioni tra il disturbo evitante di personalità ed altre condizioni che possono sembrare apparentemente simili.
Il disturbo evitante, in generale, va differenziato dai disturbi d’ansia o dalladepressione, che possono rappresentare fasi transitorie del disturbo legate alle diverse circostanze di vita, e da coloro che reagiscono con timidezza e con comportamenti di evitamento in situazioni che vivono come problematiche e stressanti.
Questo disturbo va, inoltre, distinto da altre patologie con caratteristiche simili con cui può essere confuso, che sono:
- il disturbo schizoide di personalità, in cui il soggetto non desidera costruire delle relazioni, ma preferisce la solitudine ed è indifferente all’accettazione o al rifiuto da parte degli altri;
- la fobia sociale, con cui ha in comune uno stato di attivazione ansiosa, sostenuta da una bassa autostima, che lo porta ad aspettarsi un giudizio negativo da parte degli altri; la differenza sta nel fatto che l’evitante ha un timore pervasivo in tutte le situazioni sociali e relazionali, nella fobia sociale, invece, possiamo osservare, in genere, specifiche paure correlate alla prestazione sociale;
- il disturbo dipendente di personalità (DDP), dove si presume che la persona abbia una paura di essere abbandonato, o non amato, maggiore rispetto all’evitante;
- il disturbo narcisistico di personalità (DNP), in cui ci si aspetta una conferma della propria grandezza dagli altri; l’evitante, invece, cerca inutilmente smentite alla propria inadeguatezza;
- il disturbo paranoideo di personalità (DPP), che condivide con il paziente evitante la difficoltà a leggere le intenzioni altrui, che vengono interpretate a partire dal proprio punto di vista; questi due disturbi, tuttavia, si differenziano per il fatto che il paziente paranoideo percepisce in termini di minaccia i pensieri degli altri, mentre l’evitante tende a pensare di essere oggetto di giudizio negativo.
È, quindi, necessario rivolgersi a persone competenti che possano fare una diagnosi seria ed accurata.
Il disturbo evitante esordisce nella tarda adolescenza e prima età adulta; esistono casi in cui tratti marcati di timidezza oppure di altre manifestazione dei disturbi d’ansia sociale si manifestano nell’infanzia e precedono lo sviluppo successivo di una personalità evitante.
Alcuni autori sostengono che aspetti evitanti appaiono precocemente e derivano in parte da fattori biologici temperamentali innati. Tale predisposizione biologica non sarebbe però sufficiente per determinare lo sviluppo del disturbo.
Sono state descritte come altri possibili fattori di rischio, infatti, storie di abusi fisici, storie di rifiuto da parte dei genitori, atteggiamenti che vengono rinforzati dal rifiuto dei coetanei, precoci esperienze di vita che hanno condotto ad un esagerato desiderio di accettazione e ad un’intolleranza alle critiche. Ad esempio, un bambino oggetto di continui scherzi ed umiliazioni da parte coetanei potrebbe rifugiarsi nel proprio mondo familiare, compatto e chiuso, che percepisce come rassicurante nei confronti di un ambiente esterno fatto di persone minacciose e rifiutanti, e sviluppare negli anni delle caratteristiche di personalità evitanti.
Diversi pazienti riescono a mantenere un discreto funzionamento sociale e lavorativo, organizzando il loro stile di vita in un ambiente familiare e protetto. Tendono a mantenere il proprio lavoro negandosi ambizioni di carriera e quindi di confronto; si limitano a vivere le ristrette relazioni abituali, generalmente quelle familiari. Se il loro sistema di supporto cede, tuttavia, vanno incontro a depressione, ansia e collera. L’umore depresso è una delle motivazioni che può spingere il paziente a richiedere l’intervento psicologico. Tale aspetto sintomatologico può diventare anche molto serio, per sfociare anche in ideazione suicidaria. Per affrontare il malessere legato all’ansia o alla depressione, a volte i pazienti evitanti possono fare uso di sostanze, in particolare di alcolici; tale abitudine a volte può assumere le caratteristiche di una vera e propria condotta di abuso, che va ad accrescere l’isolamento del paziente che vede la propria immagine e la propria autostima crollare inesorabilmente. Nel complesso, il paziente evitante tende ad accettare con fastidio l’abitudine alla solitudine e vive rassegnato circa la possibilità di recuperare un’accettabile vita di relazione; convive con la propria solitudine, a volte con rimpianto, altre volte con fastidio.
Differenti tipi di trattamento
Da quando il disturbo evitante di personalità è stato descritto, sono stati effettuati solo pochi studi per valutare l’efficacia clinica dei diversi protocolli terapeutici.
In generale si sono rivelati efficaci i trattamenti psicoterapeutici individuali e di gruppo con caratteristiche supportivo-espressive. L’obiettivo comune è quello di regolare empaticamente l’imbarazzo e l’umiliazione del paziente quando si trova in situazioni sociali.
Le modalità terapeutiche utilizzate sono spesso associate a strategie comportamentali e di skill training per incoraggiare l’esposizione della persona alle situazioni temute ed incrementare le abilità sociali.
I training assertivi all’interno di una terapia cognitivo-comportamentale possono migliorare l’autostima delle persone.
Generalmente, il lavoro psicoterapeutico contribuisce a diminuire il disagio emotivo delle persone e permette loro di confrontarsi con meno timori alla vita relazionale e sociale. Riteniamo opportuno consigliare simili strategie solo quando il paziente appare in grado di definire e riconoscere i propri pensieri e le proprie emozioni, ed è pronto quindi a cercare di affrontare le situazioni problematiche.
La terapia di gruppo può aiutare i soggetti a capire gli effetti che la loro sensibilità al rifiuto ha su di loro e sugli altri; riteniamo necessario non trascurare nelle prime fasi del trattamento un approccio psicoterapeutico individuale, questo per il livello d’ansia che le prime sedute di gruppo potrebbe generare nel paziente e per favorire la costruzione di una salda relazione terapeutica.
Il trattamento farmacologico viene usato in determinate fasi del trattamento e in combinazione con altri interventi, per gestire aspetti sintomatici come ansia e depressione. Vengono utilizzati ansiolitici (es. alprazolam) che aiutano a gestire la riacutizzazione ansiosa o brevi episodi di panico causati dal dover affrontare situazioni solitamente evitate, oppure farmaci betabloccanti per gestire l’iperattività del sistema nervoso autonomo che si ha quando si affrontano situazioni temute. Gli inibitori della ricaptazione della serotonina (es. fluoxetina, paroxetina) si sono rivelati efficaci nella gestione di sintomi tipici della fobia sociale, e possono essere utili nel complesso nei confronti della sensibilità al rifiuto e della timidezza.
Comunque il disturbo evitante sembra rispondere abbastanza bene alla terapia cognitivo-comportamentale a medio-lungo termine (da uno a due anni) come anche a interventi di social skills training.
La psicoterapia cognitivo-comportamentale
Il nucleo centrale del disturbo evitante è la sensazione dolorosa di non riuscire a condividere l’esperienza con gli altri e ad appartenere ai gruppi. Tale sensazione di distacco interpersonale viene favorita e mantenuta dalla difficoltà che i pazienti hanno nel monitoraggio metacognitivo, ovvero nel riconoscere e descrivere le proprie emozioni e i propri pensieri. E’ necessario allora intervenire subito su questo aspetto, poiché la non consapevolezza degli stati di sofferenza emotiva, comporta che nessun intervento di comprensione e condivisione sarà possibile.
In particolare, la difficoltà ad identificare gli stati interni, si accompagna alla tendenza a creare cicli interpersonali quando i pazienti entrano in contatto con gli altri: possono sentirsi inadeguati e per questo esclusi (“Quando le persone capiscono chi sono, mi evitano”); possono sentirsi distaccati (“Non capisco gli altri e gli altri non capiscono me”) o costretti nelle relazioni (“Sono costretto a tollerare la presenza degli altri”). Tale funzionamento alimenta il distacco interpersonale e le difficoltà di comunicazione anche nella relazione terapeutica.
Il passo seguente è quello di incrementare le capacità di collegare i propri pensieri e le emozioni che si provano alle variabili esterne; questo anche attraverso tecniche cognitive standard (come compiti di auto-osservazione, tecniche di ristrutturazione cognitiva o di role-playing).
Soltanto successivamente si cercherà di portare il paziente a sperimentare nuove strategie di padroneggiamento delle difficoltà relazionali efficaci come autoimposizione di un comportamento o l’autoesortazione per verificare e confutare all’esterno le proprie convinzioni errate circa le relazioni e acquisire o incrementare quelle abilità sociali che nel tempo si sono impoverite.
Altro aspetto fondamentale su cui intervenire è il decentramento, ovvero la tendenza che i pazienti evitanti hanno di interpretare le intenzioni e i pensieri degli altri secondo proprio punto di vista disfunzionale ed egocentrico.
Durante l’intero trattamento sarà necessario riconoscere e modulare i cicli interpersonali. Attraverso una linea strategica mirata ad incrementare l’esperienza condivisa tra paziente e terapeuta; la condivisione dell’esperienza ridurrà il rischio che il terapeuta venga percepito critico o giudicante e aumenterà il senso di sicurezza del paziente rispetto all’incontro con un estraneo quale il terapeuta.
In altre parole, il modello di trattamento metacognitivo-interpersonale è:
- aiutare il paziente a identificare le emozioni, raccontare gli eventi di vita e connetterli con l’esperienza soggettiva (incrementare il livello di monitoraggio) per modulare la sensazione di estraneità e distacco che prende i partecipanti alla relazione terapeutica;
- identificare e gli stati mentali problematici, ovvero quelle emozioni, pensieri e stati fisici, che provocano sofferenza;
- cercare di favorire momenti di condivisione tra paziente e terapeuta; la condivisione dell’esperienza ridurrà il rischio che il terapeuta venga percepito critico o giudicante;
- riconoscere e gestire in seduta i cicli interpersonali disfunzionali cercando di favorire i momenti di condivisione tra paziente e terapeuta; ciò riduce il rischio che il terapeuta venga percepito critico o giudicante.
- interventi mirati a modificare i cicli interpersonali e gli schemi che li sostengono;
- acquisire le strategie sociali per migliorare la comunicazione e la comprensione delle regole condivise socialmente;
- aiutare la persona a interpretare il funzionamento mentale degli altri abbandonando il proprio punto di vista (migliorare il decentramento);
- evitare di “evitare”.
- permettere attraverso il recupero della percezione delle proprie emozioni e della capacità di leggere adeguatamente gli stati mentali degli altri, di sperimentare un senso soggettivo di appartenenza e di condivisione.